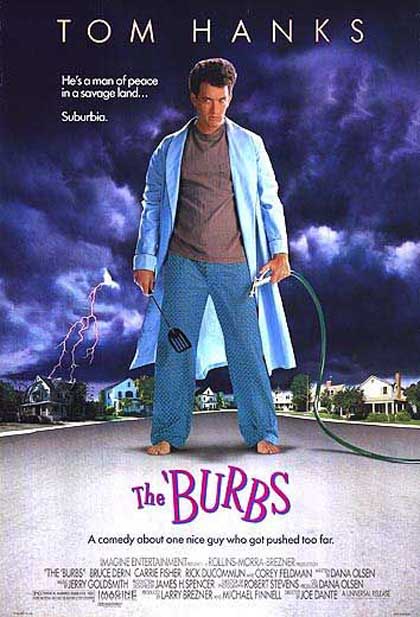Un film di Steven Spielberg. Con Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Sebastian Koch, Alan Alda. Titolo originale Bridge of Spies. Thriller, Ratings: Kids+16, durata 140 min. – USA 2015. – 20th Century Fox uscita mercoledì 16 dicembre 2015. MYMONETRO Il ponte delle spie 



 valutazione media: 3,76 su 115 recensioni di critica, pubblico e dizionari.
valutazione media: 3,76 su 115 recensioni di critica, pubblico e dizionari.
Brooklyn, 1957. Rudolf Abel, pittore di ritratti e di paesaggi, viene arrestato con l’accusa di essere una spia sovietica. La democrazia impone che venga processato, nonostante il regime di guerra fredda ne faccia un nemico certo e terribile. Dovrà essere una processo breve, per ribadire i principi costituzionali americani, e la scelta dell’avvocato cade su James B. Donovan, che fino a quel momento si è occupato di assicurazioni. Mentre Donovan prende sul serio la difesa di Abel, attirandosi l’incomprensione se non il disprezzo di sua moglie, del giudice e dell’opinione pubblica intera, un aereo spia americano viene abbattuto dai sovietici e il tenente Francis Gary Powers viene fatto prigioniero in Russia. Si profila la possibilità di uno scambio e la CIA incarica Donovan stesso di gestire il delicatissimo negoziato.
L’intro hitchcockiano cede man mano il passo ad uno svolgimento sempre più letterario, dove il racconto è già leggenda e ancora incertissimo presente, come esemplifica l’immagine tombale del muro di Berlino; e dove il Donovan di Tom Hanks sembra rispondere al paradigma dell’everyman, cappotto cappello ombrello, se non fosse che, nel cinema di Spielberg più che mai, l’apparenza in qualche modo inganna.
Donovan è infatti qualcuno che incarna il mestiere che fa, lo onora come una “professione”. Non si occupa di giustizia, è un giusto. Se a lui appare incredibile che il suo assistito non si preoccupi visibilmente del suo destino, all’altro appare inizialmente inverosimile che l’avvocato non voglia sapere la verità sulla sua colpevolezza o innocenza. “Servirebbe?” No. Per lui, che ha già fatto il proprio dovere in Normandia (salvando il soldato Ryan), ogni uomo è importante, ogni vita. Donovan non vede Abel innanzitutto come una spia, un russo, un nemico: sceglie di guardarlo come una persona. Man mano che lo conosce, gli darà un colore e una profondità, fors’anche quella dell’amicizia o dell’ammirazione, ma la scelta riguardo allo sguardo da adottare l’ha fatta in partenza. Come il regista.
Lo dice bene la prima inquadratura, nella quale Abel sta dipingendo il suo autoritratto, con l’ausilio di uno specchio. L’immagine nello specchio e quella sulla tela sono immagini della stessa persona, ma non sono identiche. La prima riflette una superficiale obiettività, la seconda reca traccia del tempo e dei pensieri intercorsi nelle ore del fare, e soprattutto reca traccia del suo autore. Non conta quello che di te penseranno gli altri, dirà Donovan al soldato Powers, ma “quello che sai tu”. Consegnando all’avvocato il dono del finale, Abel gli sta dunque dicendo: “ti conosco, so chi sei”, ed è questo il riconoscimento che più può soddisfare uno come Donovan; di quello pubblico, teletrasmesso, può fare anche a meno, può dormirci su.
In un’epoca come la nostra, di sospetti quotidiani, intercettazioni isteriche, identificazioni affrettate di un uomo col suo credo, il suo abito o la sua provenienza, Il ponte delle spie è un film di bruciante attualità, profondamente consapevole della dignità della professione artistica e della sua funzione sociale







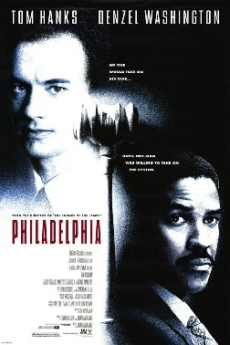

 valutazione media: 4,03 su 43 recensioni di critica, pubblico e dizionari.
valutazione media: 4,03 su 43 recensioni di critica, pubblico e dizionari.


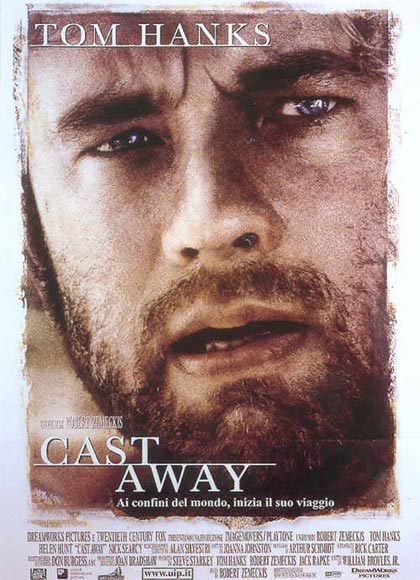 Un film di
Un film di 





 Un film di
Un film di 




 Un film di
Un film di 



 Un film di
Un film di